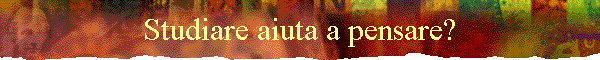La seguente
ricerca è stata accettata dal Comitato scientifico della 12th
International Conference on Thinking in Melbourne, Australia (2005) per la
presentazione durante la stessa.
Studiare aiuta a pensare?
di
Giuseppe Tidona
Abstract
Molti insegnanti hanno visto il
"riflettere" come un necessario sottoprodotto dello studio svolto in
profondità.
Questo articolo esamina la relazione tra
lo studiare e il pensare ed indaga la questione se lo "studio" in quanto
tale, rispetto ad altri processi cognitivi, sia la strada maestra per
sviluppare riflessività.
Esso presenta un esperimento condotto in
una scuola secondaria superiore italiana (l'Istituto Tecnico commerciale
Statale "F. Besta" di Ragusa) che ha coinvolto 141 alunni di 14-15 anni,
divisi in tre gruppi. Agli alunni è stata data una storia, il cui finale
era stato tagliato. Essi avevano lo stesso compito di prevedere la
conclusione sulla base degli indizi logici presenti, ma seguendo procedure
differenti, una delle quali comportava che dovessero "studiare" prima la
storia.
Tutti i gruppi hanno raggiunto una buona
conoscenza degli elementi del racconto necessari per anticipare la fine,
ma i risultati delle loro riflessioni sono stati abbastanza differenti, a
seconda della condizione assegnata loro.
"Studiare" è risultata la condizione
peggiore per pensare.
Nelle stesse situazioni le lezioni CoRT di
E. de Bono sono state provate come efficaci per sviluppare una
riflessività "produttiva".
Introduzione
Cosa significa "pensare"?
Secondo la
definizione di Bartlett, il pensare può sinteticamente essere definito
come "l'estensione dell'evidenza, in accordo con la stessa evidenza, in
modo tale da colmare i vuoti nell'informazione"1.
Il compito, inoltre, è svolto fruttuosamente solo se si seguono una serie
di passaggi intermedi che possono condurre alla conclusione più opportuna.
È difficile, in altri termini, provare ad azzardare o indovinare la
soluzione, senza considerare gli "indizi" che uno ha già di fronte e che
magari puntano in una certa direzione, indicano una strada. Può essere che
talora ciò accada, ma poi il punto di arrivo risulta convincente in tanto
in quanto, in un secondo momento, sono ritrovati ed esplicitati tutti i
passaggi intermedi.
I gap possono
essere, secondo Bartlett2,
riempiti tramite tre differenti modalità:
1.
per interpolazione (in una data serie numerica, ad es., c'è
un vuoto, un numero mancante che bisogna individuare ed inserire a quel
punto della sequenza, che poi continua);
2.
per estrapolazione (una serie numerica, ad es., è portata
avanti fino ad una certa posizione, dopo di che è interrotta, ed il
lettore deve saperla continuare logicamente);
3.
per manipolazione (quando probabilmente tutti gli elementi
di una situazione sono dati, ma deve essere trovata la relazione- o le
relazioni- esistenti tra quelli, oppure scoperta una nuova soluzione, più
soddisfacente, al di là di quelle esistenti).
D'altra parte se l'informazione fosse
davvero completa, se la verità fosse lì davanti a tutti senza lacune, di
qualsiasi tipo esse siano (e possono anche essere deficit della memoria,
se noi cerchiamo di pensare, traendo il tutto dalla nostra mente!) non ci
sarebbe alcuna necessità di pensare e tutto avverrebbe come per "istinto".
Il pensare vero è, pertanto, produttivo,
generativo.
Indubbiamente tra le tre tipologie
summenzionate, la più difficile è la terza, perché bisogna andare oltre
l'esistente: non si tratta di trovare la soluzione "giusta", secondo le
regole iscritte nei dati di fronte a noi, ma di scoprire nuove "norme" in
base a cui pervenire ad un termine.
In questo caso de
Bono parlerebbe della necessità di pensiero laterale o, per usare
una delle sue sigle (da lui impiegate per contrassegnare e rendere
immediatamente riconoscibili gli strumenti utili per canalizzare la mente
verso determinati compiti), dell'urgenza di un APC (Alternatives,
Possibilities, Choices)3.
In un articolo,
presentato dallo scrivente4
alla Quinta Conferenza Internazionale sul Pensiero Creativo, organizzata
dall'Università di Malta nel 2004, è stata esaminata l'occorrenza di
pensiero laterale (o produttivo) in ambito scolastico attraverso un
esperimento. Grazie ad esso si è visto come anche gli studenti più bravi
siano incapaci di pensiero innovativo, di andare al di là della
soluzione che sembra soddisfare a prima vista.
Tante ricerche5
hanno già confermato che anche nel più ampio contesto sociale in cui vive
ognuno di noi vede quello che è abituato a vedere: la nostra struttura
mentale di fronte ai tanti elementi fornitici, seleziona, più o meno
coscientemente, quelli coerenti con la propria cornice di riferimento,
mentre gli altri sono scartati. Per individuarli bisognerebbe costringersi
ad assegnare ad essi un valore specifico, cosa che spontaneamente non
avviene.
Con il presente lavoro si vuole esaminare
la relazione tra alcune condizioni, comuni o potenzialmente tali in
ambito scolastico, ed il pensare, come conseguenza di, o
comunque in rapporto a quelle.
In questo caso il
pensare coinvolto è stato del secondo tipo, estrapolativo (o, per
usare la terminologia di de Bono6,
capace di C&S- Consequences and Sequels, di
anticipare quello che viene dopo).
In altri termini si voleva vedere fino a
che punto gli studenti fossero capaci di prevedere logicamente, sulla base
degli elementi disponibili, il seguito di una storia, date le situazioni
diverse in cui si trovavano ad operare. È il pensare proiettivo
indifferente rispetto ad esse?
A tale scopo è stato organizzato il
seguente esperimento.
L'esperimento
L'esperimento è stato condotto nella
seconda settimana del dicembre 2004.
141 alunni di 14-15 anni appartenenti ad 8
classi differenti (5 prime e 3 seconde) dell'Istituto Tecnico Statale
Commerciale "F. Besta" di Ragusa sono stati assegnati a tre diverse
condizioni, ma dovevano raggiungere tutti lo stesso obiettivo finale:
inferire, sulla base dei dati forniti, la conclusione di un racconto, la
cui parte conclusiva era stata rimossa e che comunque sarebbe stato
possibile prevedere con un'attenta considerazione di alcuni indizi in
quella direzione di cui il brano assegnato era ricco.
Durante la prima delle due fasi
dell'esperienza, in cui veniva consegnata la copia della novella tagliata,
nessuno, però, conosceva realmente quale fosse il vero scopo finale,
ovvero prevedere la conclusione, per evitare che questa consapevolezza
"confondesse" le tre situazioni. L'obiettivo reale veniva comunicato solo
all'inizio del secondo stadio.
Le condizioni venivano realizzate o
dividendo la classe in due metà equivalenti (secondo la conoscenza
dell'insegnante di Italiano delle capacità logiche e di comprensione di
quegli alunni) ed assegnando ciascuna parte a caso ad una situazione
(realizzando così solo due dei tre stati) oppure a classi intere, ma
avendo cura che il tutto collimasse (in relazione alle possibilità di
partenza).
Le tre condizioni erano: studio,
gioco di ruolo (o di simulazione), lettura.
Esaminiamole.
Le tre condizioni: I^ fase
Le consegne differenti venivano date nelle
tre condizioni solo per iscritto, accanto alla copia della novella
"tagliata"; dunque nessuno degli studenti sapeva di trovarsi possibilmente
in una situazione particolare diversa rispetto ai compagni.
Nel primo caso
(studio) veniva detto che era una prova di apprendimento: ognuno
doveva studiare al massimo delle sue possibilità la lettura assegnata
(incompleta, perché, si asseriva, la continuazione era su un altro foglio
che sarebbe stato dato loro
in una seconda fase); trascorso il tempo
assegnato, sarebbero state rivolte delle domande scritte (questo era
quanto preannunziato) sulla storia, importanti ai fini anche della
valutazione quadrimestrale, senza poter più consultare il testo. 52
studenti hanno ricevuto queste regole.
Nel secondo caso
(gioco) le consegne erano che avrebbero dovuto leggere attentamente
il testo dato (incompleto: per i motivi addotti vedi sopra), perché dopo
avrebbero preso parte, non avendo più la novella di fronte agli occhi, ad
un gioco (non ben specificato) che partiva proprio dagli elementi del
racconto e che avrebbe avuto un certo peso per il profitto individuale.
50 alunni hanno lavorato avendo ricevuto queste norme.
Nel terzo caso
(lettura) veniva assegnato il medesimo brano interrotto, che
dovevano leggere attentamente, perché sarebbe stato importante anche ai
fini della valutazione quadrimestrale. Non veniva in quel momento data
nessun'altra consegna. 39 studenti hanno partecipato in questa
veste.
Il totale complessivo delle tre situazioni
è stato appunto 141.
La nota riguardante il profitto (presente
in ogni condizione) era stata aggiunta per avere comparabilità per quanto
riguarda l'ansia da "prestazione", che può essere un fattore impedente
quando si parla di abilità di pensare.
Il periodo assegnato a tutti per questa
parte del compito è stato di 20 minuti (che si sono rivelati più che
sufficienti); dopo si è passati alla seconda fase.
Le tre condizioni: II^ fase
In essa sono stati ritirate le copie con
la storia (tranne che agli alunni della terza condizione ai quali esse
sono state lasciate).
Alla classe è stato chiesto quanti
conoscevano la novella letta poco prima ed i nomi di queste persone sono
stati segnati, per escluderli dal conteggio finale (è chiaro che il sapere
la "fine" avrebbe invalidato la loro prova).
Sono stati distribuiti, quindi, dei fogli
bianchi che contenevano in testa solo l'invito scritto ad ognuno a
completare nel tempo previsto (15-20 minuti, elastici a secondo delle
necessità) il racconto in maniera logica e consequenziale rispetto agli
elementi forniti nella parte ricevuta prima. In effetti, sul contenuto non
c'era nessuna domanda specifica (che avrebbe potuto indebitamente
canalizzare l'attenzione!).
Anche gli studenti a cui non erano state
ritirate le novelle (lettura), hanno ricevuto le stesse consegne
degli altri.
Solo in ultimo, oralmente, una volta che
gli alunni avevano consegnato i fogli, si esaminava la conoscenza, da loro
raggiunta, dei dati rilevanti per l'obiettivo assegnato.
Su quest'aspetto non si è riscontrata una
significativa differenza tra le tre condizioni.
Alla stessa guisa le tendenze (che saranno
discusse più avanti) sono state grosso modo costanti per le classi e le
età coinvolte (14-15 anni).
Un'ultima precisazione sul racconto, prima
di esaminare i risultati.
La novella scelta,
il cui finale era stato tagliato, era il "Lungo viaggio" di Leonardo
Sciascia7.
Per vedere fino a che punto il particolare
racconto scelto potesse influire sull'esperimento, è però stata anche
selezionata ed opportunamente "tagliata" una seconda novella ("Chichibìo
cuoco" di Giovanni Boccaccio) e provata su 39 studenti: i risultati non
sono, però, cambiati.
Di seguito si offrono prima un sunto ed
alcuni estratti (i più significativi, fino al taglio) della novella di
Leonardo Sciascia e poi integralmente il racconto di Boccaccio (quest'ultimo
reso in italiano moderno dallo scrivente).
◊
I° racconto (sintesi)
La
novella "Il lungo viaggio" di Leonardo Sciascia narra la vicenda,
ambientata alcuni decenni fa, di alcuni siciliani che s'imbarcano di
notte, tra Gela e Licata, sul piroscafo del signor Melfa per andare
illegalmente negli Stati Uniti. L'uomo che, per denaro, deve portarli su
una spiaggia del New Jersey, vicino a New York, raccomanda a chi ha
parenti in America, di scrivere loro e di fissare come luogo di incontro
la stazione di Trenton (New York).
Dopo 11 giorni di navigazione vengono
convocati sul ponte dal proprietario dell'imbarcazione che mostra loro in
lontananza l'America e li invita a prepararsi per scendere. Così, dopo
essere sbarcati, s'incamminano per arrivare verso la meta prestabilita.
◊
Questa è una sintesi della parte di brano
proposto.
A questo punto il racconto s'interrompeva
e gli studenti venivano invitati a completare "logicamente" la storia.
Essa, in effetti, ha una conclusione
amara: i poveri siciliani erano stati raggirati e dopo 11 giorni di
navigazione al largo riportati di nuovo in Sicilia!
Le tracce che guidavano a questa
conclusione erano sparse nel brano consegnato.
Se gli studenti avessero riflettuto
attentamente sugli indizi esistenti fino al punto d'interruzione,
avrebbero saputo abbozzare la conclusione.
Se ne indicano i più significativi:
-
il viaggio dura meno del previsto;
-
da uno degli emigranti viene avanzato esplicitamente il dubbio che
possano non essere gli Stati Uniti (anche se non per il sospetto che siano
stati raggirati, ma perché nel mare non ci sono "né strade né trazzere"8
ed è facile perdersi);
-
il signor Melfa in risposta ostenta "compassione" e subito dopo
palesa ironia nella sua osservazione sulla diversità di "un orizzonte come
questo"9;
-
quando si incamminano, dopo essere sbarcati, incontrano prima
un'automobile che sembra una "seicento" e dopo un'altra che pare una
"millecento". Ed è strano per gli Stati Uniti!
-
Ci sono delle frecce che portano i nomi di due paesi. Gli studenti
non conoscono questi nomi, ma sanno che due degli emigranti hanno questa
reazione dopo averne letto uno: "- ….non mi è nuovo, questo nome.
- Pare anche a me;"10.
In effetti,
erano i nomi di due piccoli paesi siciliani (Santa
Croce Camerina e Scoglitti), che gli emigranti ricordavano
vagamente di avere sentito nominare.
C'è anche da dire,
in chiusura, che il tema del raggiro e dell'immigrazione clandestina, ma
questa volta verso la Sicilia, è reso di scottante attualità, per i tanti
drammi diventati oggetto di cronaca recente.
◊
II° racconto
Chichibìo
Corrado Gianfigliazzi, avendo un giorno
con un falcone presso Peretola ammazzato una gru, la diede al suo bravo
cuoco, Chichibìo, dicendogli che la cucinasse per cena. Ora mentre
Chichibìo la cucinava, passò da quelle parti Brunetta, una ragazza di cui
lui era fortemente innamorato, la quale sentendo l'odore invitante, entrò
in cucina e pregò Chichibìo di darle una coscia della gru. Chichibìo per
non fare indispettire la donna amata, le diede la coscia, pur sapendo che
questo gli avrebbe provocato guai presso il suo padrone. Infatti quando il
desinare fu pronto e servito a tavola, Corrado si accorse che mancava una
coscia. Chiamò allora Chichibìo e gli chiese che fine avesse fatto l'altra
coscia. -Oh, signore- rispose il cuoco bugiardo- le gru hanno una sola
coscia ed una sola zampa! - Com'è, com'è questa storia?- sbottò Corrado-
credi forse che questa sia la prima gru che io vedo?- Oh signore- ripeté
con calma il cuoco- è proprio così come dico io, e ve lo potrò dimostrare
facendovi vedere una gru viva.
In quel momento Corrado, per amore di
quiete, avendo peraltro degli ospiti a tavola, decise di troncare la
discussione, dopo, però, aver aggiunto:- ebbene, domattina mi farai vedere
le gru che hanno una sola zampa, ma se le gru avranno due zampe, come dico
io, ti giuro che ti concerò in modo tale che te ne ricorderai per tutta la
vita!
Il giorno dopo si recarono presso un fiume
dove normalmente sostavano le gru. Chichibìo era più morto che vivo dalla
paura: non sapeva a questo punto come riparare alla bugia. Per sua fortuna
scorse vicino all'acqua dodici gru che dormivano e sostavano solo su un
piede, come sogliono fare quando dormono. Le mostrò subito a Corrado con
aria di trionfo, ma Corrado reagì prontamente affermando:- Aspetta che ora
ti faccio vedere che hanno due zampe- e gridò violentemente:- Hohò-,
più volte di modo che le gru spaventate si svegliarono, tirarono fuori
l'altra zampa e scapparono.
-Hai visto?- disse Corrado- è evidente che
ne hanno due.
A questo punto, Chichibìo ebbe come un
lampo di genio.
◊
A questo punto la novella (liberamente
adattata rispetto al testo originale del Boccaccio) s'interrompe.
La storia si conclude in effetti con una
battuta di spirito di Chichibìo: "Ma Signore tu non hai urlato 'Hohò' alla
gru di ieri sera!", che trasforma l'ira di Corrado in una gran risata.
Gli indizi che potevano guidare alla
conclusione sono:
-
innanzitutto il tenore della novella che è in buona misura giocata
sull'azzardo: ciò si verifica una prima volta quando Chichibìo
sostiene la tesi che le gru hanno una sola zampa ed una sola coscia;
una seconda
volta quando Corrado sente il bisogno di dimostrare che in effetti
esse ne hanno due, quasi che non fosse scontato e risaputo;
una terza volta
quando Chichibìo afferma che è in grado di provare quanto detto;
una quarta volta
quando Chichibìo,
vedendo che le gru stazionano solo su una zampa se dormono, insiste nella
sua tesi;
dunque,
quando Corrado urla alle gru e fa tirare fuori loro l'altra zampa per
scappare, non può che avvenire un altro azzardo, la risposta di
Chichibìo deve necessariamente partecipare di questa categoria;
-
infine per quanto riguarda i contenuti concreti della replica di
Chichibìo, quando Corrado urla "Hohò" ripetutamente alle gru, di modo che
esse tirino fuori l'altra zampa, si dice che il cuoco ebbe un lampo di
genio, osservando quanto avveniva in quel momento (e quanto
presumibilmente non era avvenuto la sera prima). Dunque la sua battuta non
può che essere del tipo: "Ma Signore tu non hai urlato 'Hohò' alla gru di
ieri sera, per questo è rimasta con una sola coscia!"
Alcuni interrogativi
Ma quali sono gli esiti?
Se si confronta il numero di risposte
corrette con quelle errate c'è differenza tra le varie condizioni? Tra
esse qual è la migliore per "pensare"?
Fino a che punto si può dire che la
condizione più ricorrente nelle nostre scuole, quella dello studio, attivi
le capacità riflessive?
Ed è vero quello che sostengono molti
insegnanti che "studiare seriamente" (non importa sapere nei dettagli ciò
che con questa espressione si intenda nelle nostre scuole) sia il modo
migliore per sviluppare riflessività?
Il "vero studiare" è intrinsecamente
"pensare"?
Esaminiamo gli esiti, per vedere a quante
di queste domande può essere data una risposta (vedi tabella1).
I risultati
Tabella 1
| |
Condizione:
studio |
Condizione:
gioco |
Condizione:
lettura |
Totali di riga |
|
Risposta corretta |
8 |
16 |
31 |
55 |
|
Risposta errata |
44 |
34 |
8 |
86 |
|
Totali di colonna |
52 |
50 |
39 |
141 |
Nota sulla tabella:
una certa parte delle risposte
errate erano basate sulle aspettative, cioè su "quello che mi piacerebbe
capitasse ora", altre erano di pura fantasia, oppure fondate su quello che
"io ho sentito avviene in questi casi"; c'era quasi remora (anche se in
misura inferiore nella seconda e nella terza situazione) a prendere in
considerazione gli elementi reali presenti nei racconti, pur
essendo di conoscenza degli studenti. Ciò è stato appurato in un momento
successivo, quando è stato possibile ritornare in molte delle classi e
discutere con gli studenti le loro risposte.
L'analisi del chi quadrato sulla
differenza tra risposte corrette e risposte errate attraverso le tre
condizioni mostra che essa è altamente significativa da un punto di vista
statistico, X² (2, N= 141)=40,089, p ‹ ,001, 2-sided.
Osservazioni
sulla tabella
Come si vede, osservando la tabella, non
c'è uguaglianza tra studio, gioco e lettura per ciò
che attiene alla capacità di prevedere la conclusione, in quanto la
differenza tra risposte corrette ed errate nelle tre situazioni è
statisticamente significativa (vedi nota alla tabella 1).
La migliore condizione perché si verifichi
pensiero, almeno quello del secondo tipo (che sopra è stato definito
estrapolativo), è la terza, quella della semplice lettura, dopo
c'è il gioco, mentre, in effetti, lo studio sembra essere lo
stato peggiore se uno vuole che l'alunno contemporaneamente pensi! Ciò
sembra smentire il detto di tanti insegnanti che il pensiero è un
sottoprodotto dello studio.
Diverse supposizioni si potrebbero fare
per quanto riguarda tale risultato curioso: ad es. che il carico cognitivo
imposto in questa situazione impedisce una considerazione serena e
completa dei dati a disposizione, anche se in senso assoluto la condizione
del gioco non era molto diversa dal punto di vista dell'impatto
effettivo sulla memoria, eppure i risultati sono già stati
considerevolmente migliori.
Può essere che nella situazione di
studio ci sia un extra carico dovuto al tentativo da parte dell'alunno
di ricordare non gli elementi della storia, ma anche tutti i possibili
particolari, ecc.
Può essere che in questa circostanza venga
intrinsecamente meno la capacità di mettere in relazione gli elementi
presenti, la quale cosa bloccherebbe la produzione di risultati utili.
I dati a disposizione non consentono
comunque una risposta piena a tali quesiti.
Durante la fase di discussione, cui si
faceva cenno nella nota alla tabella 1 (v.), la reazione più
frequente di chi aveva dato una risposta errata è stata semplicemente:
"Adesso è tutto chiaro, ma in quel momento non ci ho pensato, non so
perché"
Si può solo ipotizzare che ci deve essere
qualcosa del processo cognitivo chiamato studio che indirizza la
mente verso altre operazioni e non verso il pensiero produttivo.
Sono indispensabili altri studi, è
necessario coinvolgere altre fasce d'età; diventa urgente replicare
ricerche internazionali, che hanno dato esiti interessanti, nel contesto
culturale italiano.
Allo stato attuale delle cose sembra
comunque che studiare in quanto tale, da solo, non sia di per sé un buon
viatico per pensare (e dunque la fiducia in esso di tanti docenti è
malriposta).
Per stimolare gli allievi, per addestrarli
al pensiero generativo (cosa che ogni insegnante considera come
essenziale) è necessario uno sforzo specifico, bisogna guidarli
progressivamente, in quanto esso non si crea con lo studio né si
sviluppa naturalmente (come tante esperienze testimoniano).
Le lezioni CoRT
di E. de Bono
Nello stesso
Istituto, il "Besta" di Ragusa (così come del resto in altri Istituti
dell'area), sono state ripetutamente applicate, a classi diverse rispetto
a quelle testate nel presente esperimento,
le lezioni CoRT di E. de Bono11,
messe a punto per sviluppare riflessività e creatività negli allievi.
I risultati di tale
insegnamento sono incoraggianti12,
per quanto riguarda l'obiettivo che si voleva raggiungere: insegnare a
pensare.
Gli ultimi dati a disposizione sono
proprio quelli dell'anno scolastico appena concluso (2004/2005) ed
anch'essi confermano gli esiti positivi ottenuti precedentemente.
E. de Bono è partito da un dato, emerso
anche dalla presente ricerca: pensare non è un sottoprodotto necessario
dello studiare. Il pensare è un'abilità specifica che può essere
addestrata e dunque migliorata, proprio come qualsiasi altra abilità, con
interventi opportuni: nessuno dubita, ad es. che un tennista che si allena
regolarmente sia più bravo di uno che non si allena mai.
Per sviluppare una qualsiasi abilità è
necessario, però, capire le parti di cui essa è composta.
Nel caso del tennis
significa comprendere, ad es., quali possano essere i movimenti basilari
della mano: i vari modi di tenere la racchetta e perciò di colpire la
palla, come eseguire un rovescio o un pallonetto, ecc.; lo stesso dicasi
per quanto riguarda i movimenti di accompagnamento con il corpo. Sono
queste cose che possono essere migliorate, non tanto il generico gioco del
tennis (e ciò vale per ogni altro sport!)13.
Allo stesso modo il "pensiero" è suddiviso
da de Bono nei suoi costituenti elementari, ognuno dei quali è indicato da
un nome specifico, molto facile da ricordare, e su essi è possibile
addestrare gli allievi.
Ogni lezione CoRT tratta proprio uno di
questi aspetti fondamentali, ma piuttosto che svolgersi come disquisizione
teorica, informazione astratta, è in massima parte condotta come
esercitazione pratica, come addestramento in situazioni concrete.
Le lezioni, nella loro versione basica,
possono essere insegnate nell'ambito di un anno scolastico per un'ora la
settimana (per 20- 30 ore circa). Esse sono adatte a studenti che vanno
dalla scuola elementare all'università.
I dati fin qui accumulati indicano che le
unità CoRT sono efficaci, mentre lo studio da solo non è sufficiente.
Avere l'informazione giusta è importante
per il proprio futuro, ancora più importante è, però, l'uso ed il valore
che si assegnano ad essa. Per questo motivo è essenziale pensare ed ogni
docente dovrebbe dedicare a tale abilità un'attenzione maggiore.
Giuseppe Tidona
e-mail:
gtidon@tin.it
Ragusa, estate 2005

1
Frederic Bartlett, Thinking- An Experimental and Social Study,
London, George Allen & Unwin LTD, 1958, p. 75.
2
F. Bartlett, op. cit., p. 22.
3
v. E. de Bono, CoRT Thinking, Blandford, Dorset, Direct
Education Services Limited, 1973-1975; vedi anche de Bono, CoRT
Thinking Program. Workcards and Teacher's Notes, Chicago, Science
Research Associates, 1987, in particolare la sezione CoRT 1.
4
G. Tidona, Thinking and Learning- The Results of an Experiment,
paper presentato alla Fifth International Conference on Creative
Thinking, organizzata a giugno del 2004 dall'Università di Malta.
5
vedi F. Bartlett, op.cit., p.175.
6
E.de Bono, op. cit, vedi la sezione CoRT 1.
7
la novella Il lungo viaggio è stata tratta dall'antologia in
adozione nelle classi summenzionate, cioè da A. Mariotti, M. C.
Sclafani, A. Stancanelli, Il libro arancione - dal Rosso e dal
Giallo, Firenze, D'Anna, 2001. Il testo di L. Sciascia è a p.160
dell'antologia.
8
L. Sciascia, p.161 dell'antologia citata.
9
L. Sciascia, p.161 dell'antologia citata.
10L.
Sciascia, p.162 dell'antologia citata.
12
Vedi, i miei resoconti "E' possibile migliorare la creatività e la
riflessività dei ragazzi?", in Dialogo, anno XXVI, n.7, ottobre
2001, Modica, pp 1-9, e "Riflessività e creatività a scuola", in
Dialogo, anno XXVII, n. 7, ottobre 2002, Modica, pp.7-8.